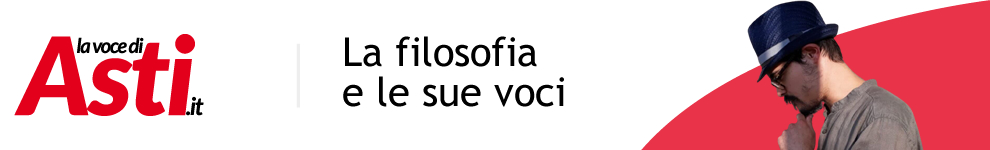Ogni felicità ha la propria forma
Terada Toru, I difensori del confine
È pressoché unanime il consenso, tra gli studiosi, ad attribuire alla filosofia antica - e non solo - lo scopo ultimo della ricerca della felicità. Il pensiero aristotelico è dichiaratamente considerato eudemonistico, ovvero orientato all'obiettivo di vivere una vita felice. Così anche la quasi totalità delle varie scuole ellenistiche, pur nella differenza di approcci e soluzioni, ritrova nella ricerca della felicità trazione principale. Considerazione generale che si può estendere anche alla nuova direzione intrapresa nella Tarda Antichità dalla riflessione filosofica nata dall'incontro con la religiosità cristiana: basti pensare, giusto per rammentarne un importante capitolo, al De Beata Vita di Agostino, laddove il concetto di felicità viene traslato in ottica religiosa, mantenendo tuttavia intatto il legame con l'antichità proprio nell'aggettivazione “beata”, che in latino, prima ancora che “beato”, significa più correttamente “felice”. Certamente, di acqua sotto i ponti ne era passata, e per questo si era resa possibile la saldatura agostiniana di vita felice con vita vissuta nell'amore divino, vita impregnata della sua qualità.
Tuttavia, la citazione da cui oggi ho preso le mosse ha una carica più universale. Non solo perché è trasversale a ogni discorso che la vorrebbe incasellare in una determinata definizione, ma anche perché raggiunge direttamente il movente di ogni indagine che si vuole eudemonistica. Concordo sul fatto che come definizione è piuttosto includente, anzi, direi decisamente deludente: è felice chi vive felicemente. Non offre troppo margine di manovra. La felicità viene relegata alla sfera personale, individuale. A una forma di introspezione, più o meno vaga, che saprebbe ricucire i fili lacerati di un tessuto troppo logorato dall'usura e dal tempo. Così intesa, della felicità non si potrebbe, a rigor di logica, discutere, tanto meno problematizzarla. A una lettura superficiale, la felicità coinciderebbe proprio con ciò di cui non si potrebbe parlare - e per questo è cosa buona e giusta tacere.
Ma ad una lettura più attenta, ci si accorgerà delle profondissime implicazioni squisitamente filosofiche (e per questo eterne). Salta subito agli occhi l'inadeguatezza della risposta intimistica: esistono tante felicità quanti sono i felici. Risposta a tutta prima corretta ad essere sincero; ma è proprio qui che interviene la filosofia. Come è possibile che le tante felicità, le multiformi felicità siano pur sempre felicità? Ora, la domanda apparentemente sembra richiamare l'annosissima questione degli universali e del rapporto con i particolari (semplificando all'osso: l'universale sarebbe la felicità; i particolari sarebbero le varie forme della felicità: la mia, la vostra, la loro…). E la richiama, in certo senso, ma solo esteriormente: influenza più il modo con il quale noi ci rapportiamo e riconosciamo le varie felicità. Insomma, dice poco sulla felicità in sé, ma molto sul nostro catalogarla. Però questa è solo una componente, una frazione delle sue implicazioni filosofiche. Più stimolante, invece, è cercare di comprendere il senso della dinamica che fa sì che si possano indagare i modi di riconoscimento della felicità. Detto più semplicemente, l'aspetto veramente interessante è che le molteplici forme di felicità sono effettivamente differenti l'una dall'altra, irriducibili l'una all'altra; sostanzialmente irreversibili, eppure pienamente reversibili, perché la mia e la vostra felicità sono pur sempre felicità…
La ricerca, allora, non può fare altro che approfondirsi, per rendere ragione di questa peculiare trama logica.