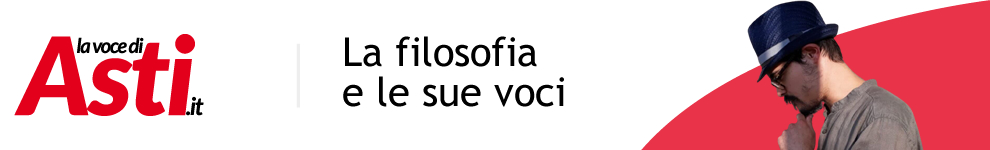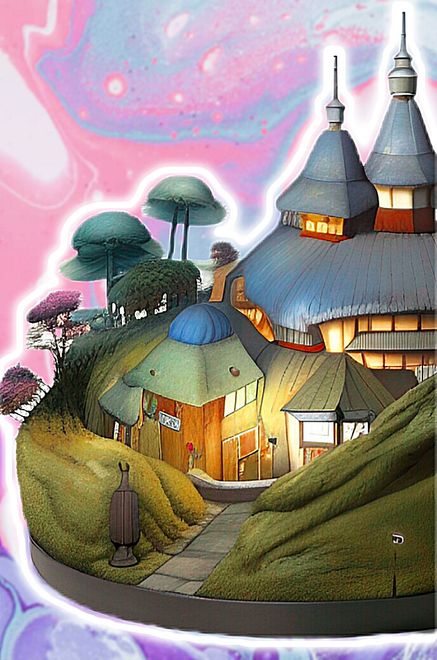Due infiniti, mezzo. - Quando si legge troppo alla svelta o troppo lentamente, non si capisce nulla
Pascal, Pensieri
Dopo una giornata intensa di lavoro o in pausa pranzo per rilassarsi un po', leggere un buon libro, lo sappiamo, può essere fortemente curativo. Scarica la tensione, aiuta l'immaginazione e tiene svegli. La lettura è una esperienza immersiva, totalmente coinvolgente: non lascia mai indifferenti perché ha il potere di cambiare sempre qualcosa in noi, indirizzandosi direttamente alla nostra interiorità psicologica e pizzicando le corde della nostra esistenza. Leggere significa creare quell'atmosfera che permette al libro di riverberarsi in noi, di prolungare la sua sostanza nelle nostre vite, di farsi, anche se solo per poco, nostra stessa sostanza. È tutto un insieme di movimenti e di scambi, di andate e di ritorno. Di lettura in lettura noi si cresce, si impara. Si vive.
Queste brevi considerazioni sono oggigiorno oggetto dalla cosiddetta atmosferologia, branca della filosofia contemporanea che affonda le sue radici nella fenomenologia - corrente filosofica su cui ritorneremo sicuramente nelle prossime puntate data la sua importanza. Ma possiamo renderle valide anche per il pensiero di Blaise Pascal, vissuto in pieno 1600? Ovviamente no, se ci limitiamo alla lettera dei suoi scritti. Ma sì, sebbene solo in parte, se la nostra domanda si posa sul senso possibile delle sue affermazioni.
Di primo acchito, sembra riproporre l'arcinoto principio etico dell'aurea mediocritas: la virtù non è nell'eccellenza smargiassa né nell'auto-umiliazione dimessa, ma in quella medietà che sa trarre il meglio dalle due componenti e scartare gli eccessi in ambo le direzioni. Il giusto mezzo aristotelico, la misurazione e la moderazione - est modus in rebus. Di per sé non è una diagnosi sbagliata. Solamente è incompleta. Perché il bersaglio di Pascal è in questo frammento, come in moltissimi altri presenti nei suoi Pensieri, il buon Cartesio. Difatti, quest'ultimo si era macchiato di una grave colpa filosofica, per così dire: separare irrimediabilmente soggetto conoscente e oggetto conosciuto che vengono considerati rispettivamente res cogitans - cosa pensante - e res extensa - cosa estesa. Le due componenti della realtà, così operando, si trovano ad essere sostanze esterne l'una all'altra. Il soggetto opera sulla natura, la cosa estesa, e essa, docilmente, si adegua alle sue regole (regole per altro valide incontrovertibilmente perché affondano la loro legittimità in Dio, che non fa altro che accordare, con la sua volontà onnipotente, la perfetta aderenza del lume razionale della res cogitans alla quiescenza della res exstensa). Siamo al cospetto di una dicotomia, di una contrapposizione e di uno squarcio senza possibilità alcuna di ricucitura (per quanto Cartesio abbia provato a fornire una lettura conciliante in Le passioni dell'anima, i filosofi postcartesiani si sono trovati alle prese con la ricomposizione del lacerato).
E in questo consiste la critica di Pascal. Non un giusto mezzo tra una lettura assai rapida e una assai lenta, ma l'individuazione di un piano terzo, più profondo e invisibile: il piano della lettura da cui si originano gli estremi stessi. La dicotomia è abbandonata proprio perché irrimediabile. L'assai lento e l'assai veloce resteranno sempre sue dinamiche contrapposte, ma dinamiche di una atmosfera della lettura originaria, più fondamentale delle strade imboccate e che le rende tali.