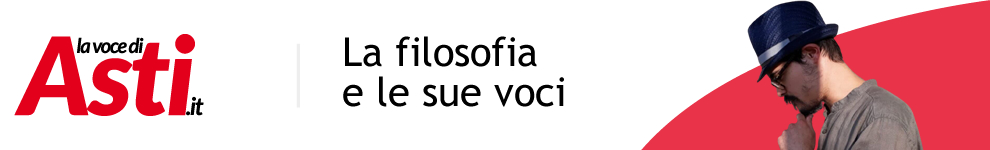Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire
Italo Calvino, Perché leggere i classici
Anche questa affermazione è divenuta a sua volta un classico. E questa forse segna quanto avesse ragione Italo Calvino: leggere un classico è sempre una rilettura che ha il gusto il della prima volta, che ha il piacere della scoperta ad animarla, ma anche la certezza della piacevolezza e del godimento. È sempre una prima lettura la rilettura di un classico: un fondo inesauribile sembra parlare dal suo nascondiglio, un'umanità antica eppure vivida che da quelle pagine e tra quelle parole si snoda e ci attraversa, ci trapassa e passa. Ai nostri figli, ai loro figli e così via. Anche l'affermazione di Calvino è divenuta un classico, perché la rileggiamo e la apprezziamo, meglio di prima, oggi meglio di ieri e domani meglio di oggi. Il suo dire infinito ci parla con un dire che non dice nulla di che in fondo, ma che dice ciò che è da dirsi, qualunque cosa esso sia. Non dice che fare, che non fare: non dice nulla, per questo è inesauribile. Eppure dice. E mostra. Dice mostrando. Mostra che quello che è stato detto non è stato detto per mostrare che il discorso sarebbe stato interrotto; mostra dicendo che tutto è ancora da dire e che noi, lettori che leggiamo quanto detto per la prima o la seconda o la terza volta - poco importa - dobbiamo ancora dire quando detto inesauribilmente in quel classico…
Ma questa è letteratura. E le cose funzionano così. Bene. Ma in filosofia? Davvero un classico è ciò che non ha mai smesso di dire quanto ha da dire? E dove possiamo tracciare la linea demarcatoria di ciò che ha smesso di essere valido e di ciò che ancora possiede spessore? La ghiandola pineale cartesiana ha ancora un senso? Eppure Cartesio è un classico. Scartiamo quella per salvare il resto? Eppure è stata una trovata importante per il suo intero impianto filosofico. In filosofia la classicità di un testo è un affare di grande importanza. Perché è importante leggere oggi i classici del pensiero filosofico? Le risposte possibili sono molteplici: ci insegnano un metodo filosofico, un modo di procedere razionale che razionalizza il questionare stesso (importanti sono le domande, ma altrettante come esse vengono composte); ci insegnano il linguaggio delle tradizioni filosofiche; ci pitturano un fantastica storia fatta di idee e di scontri, di errori e trovate geniali; ci accompagnano alla ricerca di risposte condividendo i medesimi problemi o ci conducono a risposte differenti per differenti questioni; ci riconducono in una continuità diacronica permettendoci di affrontare la nostra discontinuità sincronica. Sono le testimonianze di amici lontani.
Ma c'è ancora una cosa che vorrei sottolineare: i classici sono inesauribili perché ci costringono a ricominciare. Un classico filosofico è lo snodo meno neutrale che possa incontrare uno studente, uno studioso o un appassionato. Passare attraverso le sue pagine vuol dire essere attraversato dalla vertigine delle domande, da quella presa di coscienza dello stupore della percezione, della vastità del cosmo. Vuol dire ricominciare da capo la ricerca, prendere strade non battute, incontrare amici inaspettati e nemici non preventivati. Leggere un classico non è un'avventura. L'avventura, inizia dopo.