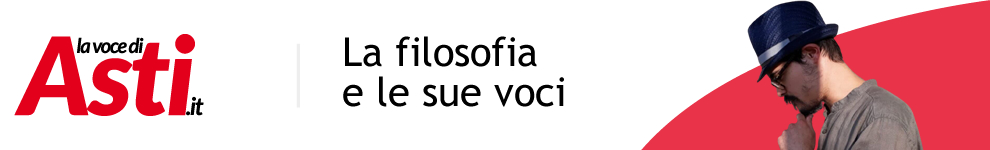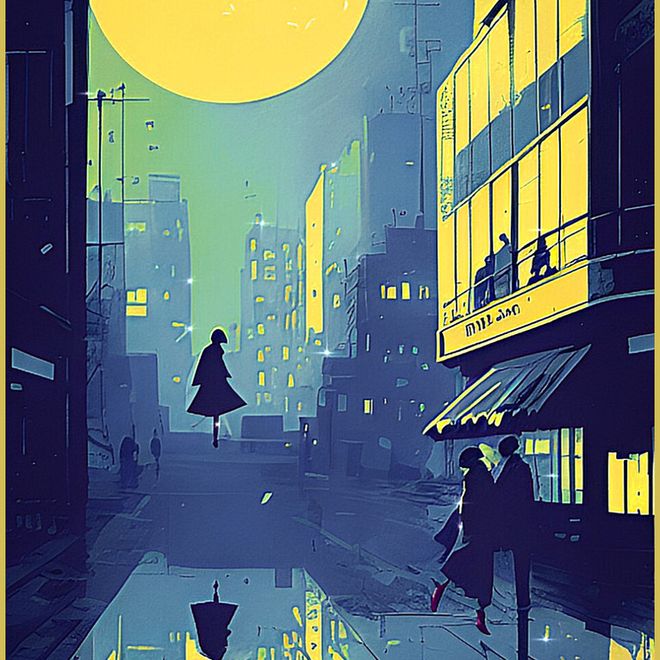Come è possibile non percepire, allora, la tristezza al fondo della vita moderna?
Fukada Yasukazu, La danseuse de Degas (traduzione mia)
Jean-Michel Abrassart e Omata Takako nel primo volume dell'European Journal of Japanese Philosophy (2016) hanno offerto ai lettori occidentali una prima traduzione francese di un saggio del filosofo ed esteta nipponico Fukada Yasukazu (1878-1928) dedicato alla descrizione della Danzatrice di Degas. Il primo tratto distintivo del testo è l'emergenza di un senso di malessere che coglie il pensatore orientale alla vista di una città caotica e confusionaria come Parigi. Confusione che viene acuita dopo la visita al Musée du Luxembourg, che presenta una panoplia di quadri e opere affastellate come a saturare, vittime di un horror vacui invincibile, lo spazio vuoto di una pienezza debordante. Una carrellata di opere schierate senza il minimo interesse - e senza la necessaria competenza - per una disposizione più filologica e maggiormente atta all'apprendimento della storia dell'arte. Il museo sarebbe così diretta espressione della disfunzionalità delle società moderne: siamo agli inizi del '900 e dalla seconda metà del XIX secolo il continente europeo aveva fatto dei passi in avanti enormi, sia per quanto concerne lo sviluppo tecnologico che per la sua applicazione tecnica al mondo dell'industria. Ma queste oggettive migliorie in molti ambiti, avevano sortito il medesimo effetto in relazione alla vita sociale quotidiana? Da Baudelaire a Freud, difatti, numerosissime sono state le denunce dei mali delle società moderne.
E ora? Valgono ancora quelle parole sferzanti, quel grido disperato al cospetto dello sfaldamento di consolidare strutture, oppure devono essere intese come un borbottio di sottofondo, magari spinto più che altro da invidia sotterranea? A opinione di chi scrive, valgono ancora - certo in parte, non completamente e con una necessaria revisione. Perché non si può, comunque la si pensi, abdicare al sano impegno della critica in favore di una più accomodante visione del mondo che accetti la realtà così come è. Il mio non vuole essere il solito discorso un po' barbogio, riassumibile nell'abusatissimo motto "si stava meglio quando si stava peggio"; quanto più una sincera interrogazione della situazione nella quale ci veniamo a trovare.
Per questo la domanda proposta più di un secolo fa mi sembra ancora estremamente attuale. Come non accorgersi della tristezza che serpeggia nelle nostre città? D'altronde, essa era anche il nemico numero uno di Spinoza: la tristezza ci indebolisce, riduce la nostra potenza, impedisce la nostra espansione (da non intendersi in senso letterale, ovviamente); ci ferma al palo, ci rende attendisti, sperando in un non ben identificato qualcosa che forse non avverrà mai. Ciò che tarda avverrà è il titolo di un libro di Paolo De Benedetti: ma bisogna almeno sapere, o credere, in quel "ciò che tarda", perché se quel "ciò" non si sa cosa sia, difficilmente ci si accorgerà della sua venuta.
Non sto dicendo che le nostre società siano votate allo sfacelo della sfiducia. Dico solo, e le contemporanee filosofie della cura lo sottolineano puntualmente, che viviamo in tempi fragili, e che in fragili tempi ancor più fragili sono coloro che vi abitano. Che sia un effetto collaterale delle società moderne - chiamatele ora post-moderne, poco importa - questo mi è oscuro. Ma quanto sarebbe bello, anche solo per provare, danzare in tempi fragili?