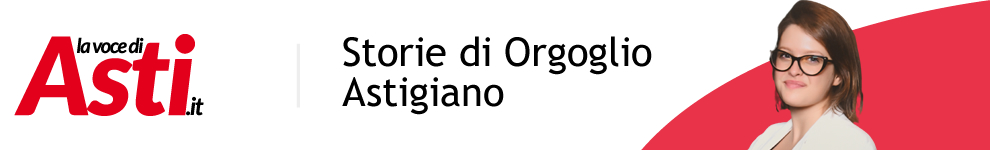Per accompagnarti nella lettura di questa intervista ti consiglio la canzone Marmellata #25, di Cesare Cremonini, contenuta nella playlist "Orgoglio Astigiano" su Spotify
Conosco Ivano Deltetto da qualche mese. Amico di amici, era stato uno dei primi fan del progetto di Orgoglio Astigiano, soprattutto quando aveva messo radici nel mondo scolastico astigiano. Dopo aver fatto un evento insieme, conosco ancor di più la sua storia di vita. Ne resto affascinata: la voglio raccontare.
Ivano, che rapporto hai con l'Astigiano?
Sono di San Damiano, ho vissuto lì per 30 anni (ne ho 47), poi mi sono sposato e mi sono trasferito a Frinco, dove vivo tuttora. Il rapporto con il territorio è sempre stato molto stretto e sentito. Tengo tanto all'Astigiano.
Cosa facevi prima del "grande sogno"?
A San Damiano ero in Croce Rossa. Dal trasferimento a Frinco ho iniziato a lavorare nell’ambito del vino, facevo l'enologo in un’azienda a Nizza Monferrato. Ci sono stato un paio d’anni. E poi un giorno ho deciso di partire per l’Africa: era il mio grande sogno.
Con quale scopo raggiungi l'Africa?
Attraverso il Cefa, si ricercava la figura di un agronomo per una Ong di Bologna. Ho mandato il curriculum, ho fatto il colloquio, sono stato selezionato per questa opportunità e mi sono portato anche mia moglie. Non sarei mai partito senza di lei. E il caso ha voluto che ci fosse lavoro anche per lei. Questo succedeva nel 2009. Annunciamo la nostra partenza per l'Africa, in particolare la Tanzania, con un evento al Dlf. In Tanzania facevo il capo di questo progetto del Ministero degli Affari Esteri, mentre mia moglie Silvia faceva l'animatrice rurale.
Come funzionava la vita lì?
Vivevamo in un villaggio di circa 10mila abitanti, ma c’era una miriade di quartieri. Si chiama Ikondo. E mi sono occupato di agricoltura, avevamo una latteria, facevamo il formaggio. Prima del nostro arrivo, al villaggio il latte si beveva crudo, da appena munto, e basta. Noi, pastorizzandolo, facevamo formaggi, yogurt, caciotta, mozzarella. Pensa che la nostra mozzarella era talmente buona che la esportavamo nel resto del paese: era più comodo importarla internamente che non farla venire dall'Europa. Nella zona più vicina a Zanzibar, quella più turistica, c’erano tante pizzerie che ce la richiedevano. E poi avevamo 80 ettari di girasole, una falegnameria, un laboratorio per la produzione di olio di girasole. Quando siamo arrivati, uno degli obiettivi era quello di riabilitare la strada che dal centro portava alla città più vicina, a quattro ore di macchina. Una strada non asfaltata.
Come si collega questo alla tua passione per le api?
Nel tempo libero continuavo a coltivare la mia passione per le api. Non c’era la tv, internet andava e veniva, i film nell’hard disk erano finiti presto. Mi ero portato un libro da leggere sulle api. Api che lì sono particolarmente selvagge. Andavano a colonizzare le cassette di derivazione elettrica. Il problema è che essendoci una centrale idroelettrica, quando le api entravano scoppiava tutto e il villaggio restava puntualmente senza corrente. Inoltre, c'era anche un'altra questione. Nel villaggio c'erano cinque asili, con 100 bambini circa per ognuno. Uno dei pasti tradizionali era l'uji, un alimento fatto dalle maestre per i piccoli dell’asilo, con zucchero e farina di mais bianco che veniva prodotta in loco. Lo zucchero aveva comunque un costo. Da lì mi sono chiesto: ma con tutte queste api, se lo facessimo con il miele? E così si è iniziato a trasformare un problema in un'opportunità per tutto il villaggio.
Da dove sei partito per dare vita a questo progetto? Hai riscontrato difficoltà, diffidenza da parte degli abitanti del villaggio?
Innanzitutto la prima difficoltà è stata quella di trasferire le api dalle cassette di derivazione alle arnie, che però abbiamo dovuto produrre in Africa. Io ne avevo portata una dall'Italia, un esempio, ovviamente smontata. E così avevo chiesto a chi lavorava nella falegnameria del villaggio di riprodurmene dieci. Non è stato semplice: il miele in Africa viene considerato come medicina, non come alimento in sé. Esistono i cosiddetti "docta jayadi", dottori che usano metodi antichi, erbe particolari, per guarire le persone. Per loro le api erano cura, medicina e noi, invece, andavamo a governarne la produzione. Inizialmente ci siamo dovuti scontrare con una certa diffidenza. È andata però. Fino a quando ho avuto un incidente in macchina.
Che incidente hai avuto?
Un giorno, nel giugno 2011, durante la stagione secca, era tanto che non pioveva e la strada era diventata scivolosa. Ero in macchina, stavo facendo una salita molto ripida. Purtroppo l'auto non è riuscita ad arrivare alla cima, è tornata indietro, ha iniziato a rotolare su se stessa, uscendo fuori strada e finendo in un dirupo. Sono stato sbalzato fuori dalla macchina. Dopo l'incidente ho fatto sette ore di viaggio verso il primo ospedale locale, ma non avevano le attrezzature adatte, a parte un macchinario per fare i raggi. Avevo un ematoma in testa e così ho fatto altre sette ore verso un altro ospedale, in cui sono stato un paio di giorni. Il tempo di organizzare il viaggio in elicottero verso il Kenya, a Nairobi in particolare. Ricordo che da quell'elicottero vedevo panorami mozzafiato, leoni, giraffe: uno spettacolo bellissimo. All'ospedale di Nairobi sono stato una settimana, volevano operarmi alla testa, ma non ho dato il consenso. E così la Farnesina ci ha organizzato il viaggio di ritorno in Italia. Bollettino? Trauma cranico e due vertebre rotte.
E dopo l'incidente e il tuo ritorno in Italia cosa succede?
Non sono più rientrato in Africa, ma mia moglie sì. Per quattro mesi, mentre ero in Italia, Silvia era in Tanzania a fare il doppio lavoro. Poi è rientrata anche lei. Ad Asti ho ricominciato a lavorare come enologo, per la Ramazzotti di Canelli. Fino a che un caro amico, che lavorava per la cooperativa sociale torinese Ecosol, mi parla di un progetto all'interno del carcere delle Vallette, sul vivaismo e produzioni orticole. Alle Vallette su questo progetto ci ho lavorato un anno e mezzo. Così salutavo i miei due anni in Africa.
Cosa ricordi nello specifico dell'esperienza alle Vallette? Ci sono scene che ti hanno particolarmente segnato?
Tantissime, a dire il vero. Una fra tutte quando, in orario di pranzo, interi blocchi che non avevano da mangiare, prendevano i piatti di metallo e li sbattevano contro le sbarre delle celle. Avevo la pelle d’oca: ce l'ho ancora al solo pensiero.
Api e sociale: le tue due 'vocazioni'?
Nel frattempo, comunque, continuavo a coltivare la mia passione per le api e così ho iniziato ad allevare. Ho scelto le api, ma senza lasciare la parte sociale: erano e sono, di fatto, le mie due 'vocazioni', che ho scelto di unire. Nel 2015 ho aumentato la dimensione della mia azienda , con un occhio al sociale. Mi sono messo a disposizione per progetti legati all'apicoltura in paesi in via di sviluppo. Sono di nuovo ripartito per fare consulenza per un'associazione della Sicilia, poi in Mozambico, sempre per il Cefa, collaborando anche con la cooperativa La Strada per implementare le api nel carcere di Asti (che ora ospita circa 15 arnie). Ho anche tenuto un corso sulla produzione di pappa reale a una ventina di ragazzi richiedenti asilo, grazie a un'associazione di Alessandria, che si chiama Cambalache.
Conti di tornare in Africa?
Assolutamente sì, continua a essere il mio grande sogno. Sarei dovuto partire ad aprile di quest'anno, alla volta della Costa d'Avorio, con un'associazione tramite l'Enaip Piemonte, per un progetto sul riso. Purtroppo ho dovuto rifiutare, sto facendo il concorso per entrare di ruolo a scuola. Attualmente insegno al Castigliano di Asti. Sai, l'Africa mi è rimasta nel cuore. Lì si dice che chi va in Africa e ci sta un giorno scrive un libro; chi ci va un mese scrive un articolo, ma chi ci sta un anno non scrive nulla, cerca solo un modo per ritornare.
Un consiglio agli astigiani dall'esperienza africana?
Sicuramente fare più comunità. Ho notato che in Africa, pur essendo in estrema povertà, le famiglie si aiutavano sempre a vicenda. Se moriva qualcuno e rimaneva un figlio da solo, questo diventava subito figlio di un'altra famiglia. In Africa c'è l'idea di un aiuto reciproco e un senso di comunità che in Italia non ci sono più, che abbiamo perso. Servirebbe avere meno paura del diverso e nell’Astigiano penso che sia invece molto spiccata. Lo vedo anche a scuola o in generale spesso i ragazzi che arrivano da paesi in via di sviluppo hanno problemi di lingua e non vengono aiutati a integrarsi. Si creano ghetti sociali, che invece dobbiamo fare il possibile per evitare.
Un consiglio ai giovani, invece?
Rischiate. Al massimo avete fatto un’esperienza. Cercate di fare ciò che volete, al massimo delle vostre capacità. Rischiate, ma impegnandovi, perché se veramente vuoi qualcosa, allora ti impegni davvero per ottenerla. Non esiste il non ce la faccio, servono impegno, forza di volontà e idee chiare.
Pensi che il territorio astigiano si voglia sufficientemente bene?
No. Gli stessi amministratori cercano di 'arrivare a fine mese'; c’è sempre qualcosa che è più importante rispetto agli aspetti sociali della vita dell’Astigiano. Ci sono sempre altre priorità. Servirebbe una maggiore attenzione al welfare, alla dimensione sociale: le comunità starebbero meglio. Anche perché funziona così: ciò che lo Stato non riesce a fare lo farebbero gli amici, gli amici degli amici e così via. I rii una volta, quando pioveva, non davano mai problemi, mentre ora rischiamo le alluvioni perché gli agricoltori li pulivano, a livello comunitario. Ora non si ragiona più in ottica comunitaria, ci dovrebbe pensare l’amministrazione, ma non ha soldi, poi ci sono problemi di burocrazia e la gente muore.
In Africa c'è una sorta di servizio civile permanente, in tal senso?
In Africa c’era il concetto del 'maendeleo', che letteralmente, in swahili, vuol dire progresso. Per le popolazioni della Tanzania era una messa a disposizione della singola persona verso la comunità, per almeno un giorno al mese. Grazie a questo, quando abbiamo rifatto la strada, migliaia di persone sono arrivate con la loro zappa e si sono messe lì a lavorare. Noi offrivamo loro solo del cibo. Diciamo che se ci fosse almeno un po' di questo spirito anche qui sarebbe bello. Tutto ciò fa pensare a quanto siamo indietro, a quando siamo andati indietro.